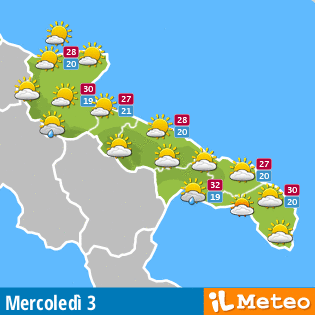“Le mie ‘madeleine’ sono gli involtini” / IN UNA GEOGRAFIA DELL’ ANIMA, A SANTA ROSA, IL QUARTIERE DEL CUORE
Nella mia geografia dell’anima la capitale è Santa Rosa. Qui sono nato e qui ho vissuto fino a vent’ anni, prima di andare via. Qui, dopo altri trenta, sono ritornato ad abitare da pochissimi anni.
Condivisi il destino in comune di questa città, i cui abitanti partono e poi sognano di ritornare, oppure restano, sperando di andare via presto.
Io sono tornato da poco, dopo tantissimi anni. E sono tornato da dove partii, sono tornato a Santa Rosa.
E da quando son tornato mi esercito continuamente a comparare i due lati della frattura temporale che separa, ma non divide, la geografia dell’ anima.
Ieri ho incontrato uno dei “don Salvatore boys” dell’ epoca, che, commuovendomi, perché mi ha chiamato “Pinuccio”, come solo i “vecchi” abitanti del quartiere fanno, mi ha abbracciato.
La settimana scorsa ho risentito per strada il profumo del sugo di carne con gli involtini.
***
Era appena sorto dal nulla, cioè dalla campagna, come nella canzone di Adriano Celentano. La mia via Gluck aveva nome Coronatelli, ma in seguito, pur rimanendo la stessa, prese il nome di Giovanni Verga.
C’erano le palazzine linde e ordinate, a gruppi e a isolati, i giardinetti, le panchine, una scuola elementare appena finita. C’era la chiesa, un giovane parroco, don Salvatore De Giorgi, che poi sarebbe diventato vescovo, e poi ancora cardinale. Don Salvatore, come continuano a chiamarlo qui tutti i suoi parrocchiani di un tempo, a Santa Rosa torna ancora adesso ogni volta che può e ogni volta è sempre una festa per tutti. A me, piccolo chierichetto, insegnò a leggere, o meglio, a declamare, a parlare in pubblico, a saper stare in mezzo agli altri.
Non torna più invece il parroco che lo sostituì, prima di diventare vescovo anch’egli, don Vito De Grisantis, perché è morto da qualche anno, però il suo ricordo è ancora adesso parte integrante del quartiere.
***
A mano a mano che le costruivano, le palazzine basse, colorate, si animavano e le case venivano comprate, e quindi curate, animate, tenute con amore, da altrettante famiglie semplici, operose, monoreddito, con figli, di militari, impiegati, operai, che pure divennero tutti proprietari, in quegli anni Sessanta del così detto “boom” il cui suono si ascoltava pure in quella remota periferia di una città non solo di periferia, ma pure del Sud, e anzi, come diceva il suo figlio più illustre, Carmelo Bene, al Sud del Sud dei Santi, con le Cinquecento e le Seicento che spuntavano parcheggiate fra le stradine del quartiere, con le antenne rudimentali che contorte si levavano sui terrazzi delle palazzine. C’erano tanti bambini e le grida dei loro giochi nei giardinetti, fra le panchine colorate, erano la voce più squillante e più piacevole dell’intera zona.
Poi, non ci furono più.
Forse furono i tempi che cambiavano, in teoria in meglio, in pratica sostanzialmente in peggio, forse l’inadattabilità del luogo, forse i problemi che spuntarono, le mutate condizioni del pubblico e del privato, o forse chissà che.
Il mio quartiere piccolissimo borghese a poco a poco non fu più lo stesso, quel suo decoro cominciò a scemare.
Anche la mia infanzia, povera, semplice, bellissima, piena di amicizie, di scoperte e di emozioni, pure la mia adolescenza, animata da sacri furori ideologici, ma soprattutto di desideri di conoscenza, finirono una dopo l’altra.
***
Pure il così detto “ceto medio”, nel frattempo, è una categoria sociologica che non esiste più, mentre una volta era la parte sana e buona della società dei giorni nostri, in cui ancora sono scomparse tante altre cose sane e buone.
Ogni volta che, per una ragione o per l’altra, capito a Roma, mi piace soggiornare all’Eur, che sento proprio mio, come se fosse aria di casa, in particolare dalle parti del Palazzo dei Congressi e del Laghetto; poi, mi piace sempre fare comunque un giro dalle parti del Flaminio e del villaggio Olimpico, perché fu la prima zona della capitale che conobbi, la prima volta che ci andai ancora ragazzo e niente avviene mai per caso.
Mi piacciono comunque quei palazzi imponenti, che al tramonto si svuotano e si trasformano in silenziosi, vagamente inquietanti, nella loro metafisica presenza, alloggi spettrali, specie nei loro portici; quelle grandi strade piene, prima, poi deserte, e quelle piccole che segnano di spazi fra un palazzo e l’altro; quell’atmosfera di composta solennità e di rassicurante affermazione; quel traffico che passa da caotico a rarefatto; quel passaggio di adattamento da un’epoca, all’altra, dal fascismo degli anni Trenta, allo spirito del boom economico, degli anni Sessanta, da cui è segnato tutto l’Eur; e quell’analogo spirito di palingenetica metamorfosi che segnò il Villaggio Olimpico quando fu riconvertito nelle case per gli impiegati dello Stato, pure con i successivi nuovi passaggi, da degrado e abbandono, a dignità e decoro.
A Santa Rosa, a casa mia, non c’è il laghetto, ma c’è una fontana, per quanto sia sempre spenta e risulti quindi surreale, nel degrado cui l’ hanno condannata l’ incuria egli amministratori.
Ci sono i portici fra le palazzine, basse, e le villette, e le stradine degli interni che al tramonto, pure d’estate, sembrano abbandonate, nel silenzio vagamente inquietante, eppure vissuto, partecipato, e quindi pure al tempo stesso rassicurante.
Certo, una cosa è l’Eur e come e perché nacque e un’altra il villaggio Olimpico; un’altra cosa ancora Santa Rosa.
Ma, cercando una documentazione su internet, ho fatto un scoperta importante e per me rivelatrice: un architetto romano, Francesco Berarducci che ha lavorato ai progetti per l’edilizia residenziale a Roma è lo stesso che progettò le palazzine Ina casa al quartiere Santa Rosa a Lecce.
Ecco, ecco il perché di quei volumi essenziali, di quell’insieme di composto e richiamato decoro, di quegli spazi insistiti, e di tutti quei particolari che, se non nel complesso, di sicuro in tanti dettagli, mutatis mutandis, richiamano alla stessa origine ideale! La stessa mano, la stessa aria, di casa, è proprio il caso di dirlo!
***
Le origini di Santa Rosa a Lecce vanno ricercate negli anni Cinquanta, quando prese il via un piano imponente di edilizia abitativa, detto INA – CASA.
Ci tocca rimpiangere la Prima Repubblica, in seguito deteriorata e implosa nel suo sistema bloccato, travolta infine dalla corruzione, ma all’origine sana quanto basta e soprattutto seria, così stanno le cose!
Fu una realizzazione politica fatta davvero per bene, anche per le idee di fondo che sottintendeva e da cui era animata: una specie di solidarietà di massa, parcellizzata sul territorio nazionale; un’opportunità concreta per i senza – tetto, o per i precari abitativi; la ricostruzione effettiva, un invito vero a riconciliarsi con la società, partendo dal soddisfacimento di un bisogno primario.
Fra l’ altro, impiegando i soldi degli Americani e fregandoli, perché essi avrebbero voluto che fossero destinati ai consumi.
Oggi, più che costruire, bisognerebbe ricostruire. Oggi poi bisognerebbe dire basta alle speculazioni del privato, che tanti scempi edilizi hanno prodotto nelle note città e che comunque sono all’origine delle sperequazioni sociali esistenti.
Oggi acquistare una casa è stato prima, fino a poco fa, collocarsi una specie di capestro, di nodo scorsoio al collo, col mutuo bancario, che così adesso soffoca le famiglie italiane e, complice anche le tassazioni insostenibili, ha contribuito alla scomparsa del ceto medio, un tempo diffuso e vera e propria spina dorsale animatrice della Nazione italiana; e poi, è diventato praticamente impossibile, per i giovani debilitati dal precariato e storditi dalla mancanza di fiducia.
Il piano INA – CASA, detto anche piano – Fanfani, dal nome del poi celebre ministro del lavoro e della previdenza sociale Amintore Fanfani, diede un’abitazione a decine di migliaia di Italiani, specialmente quelli meno abbienti, realizzando nell’arco di poco più di un decennio trecento cinquantacinquemila unità abitative, assegnate al ritmo di cinquecentocinquanta a settimana ad altrettante famiglie. Tutte proprietarie, ed è il capolavoro sociale del piano: infatti, la casa si pagava nel tempo con una trattenuta mensile dello 0,6 % sullo stipendio, mentre il doppio era a carico del datore di lavoro.
Insomma, se una legge prevedesse e realizzasse qualcosa di simile ai giorni nostri, anche un giovane “precario” da mille euro al mese di una famiglia monoreddito potrebbe abitare – e da proprietario – in una casa decorosa, con sessanta euro mensili.
Ancora, allora nelle varie città i lavori furono affidati a piccole imprese, che a loro volta si servivano di mano – d’opera locale e quindi ebbero un’occupazione stabile altre decine di migliaia di lavoratori.
Infine, materiali e realizzazioni, ispirate a un sano neorealismo abitativo, una funzionalità felicemente in bilico fra tradizione e modernità, interpretavano e reinventavano gli spazi, con attenzione pure agli spazi – verdi, piccoli, ma funzionali, anche quale luogo di aggregazione, non rinunciando nemmeno a particolari architettonici degni di nota, come le opere d’arte qua e là disseminate da un angolo all’altro, l’ultimo dei quali era la targa policroma in ceramica, che richiamava l’idea della casa quale luogo felice, posta su ogni palazzina.
Mai più in seguito è stato fatto qualcosa di simile, anzi, lo Stato, le classi politiche che si sono succedute negli anni seguenti, dalla Prima alla così detta Seconda Repubblica, dal centro – sinistra e dal compromesso storico degli anni Settanta, a quello di Craxi, Andreotti e Forlani degli anni Ottanta e primi anni Novanta; da Berlusconi, a Prodi, fino a Monti, Letta e Renzi; tutti hanno lasciato mani e piedi il settore in balia della speculazione privata, con i guasti fisici e sociali cui ho accennato, fino a rendere il bisogno primario della casa un’altra emergenza e un problema conflittuale, se non addirittura un miraggio, per la grande maggioranza degli Italiani, divenuti nel frattempo sempre più poveri e soprattutto sempre più sfiduciati e insicuri.
***
Correva l’anno 1960. In una foto dell’epoca lo si vede a bordo di un’auto scoperta, circondato da questurini gioviali, percorrere a passo d’uomo la via di piazza Indipendenza, lungo i portici, delle palazzine adornate dai tricolori sui balconi.
La storia siamo noi. Là e di lì a poco, arrivato nel quartiere che anno dopo anno si ingrandiva, pronto per la scuola elementare, cominciò veramente anche la mia.
***
L’ infanzia era felice, fatta di giochi con i coetanei, di condivisioni, di tranquillità, di serenità, e nutrita di valori trasmessi dalle famiglie.
Questo ricordo diventa tristezza, nel constatare che oggi i bambini non giocano più a pallone per strada; non scaricano energie fisiche, né ricaricano quelle mentali, facendo estenuanti attività fisiche “giù” da casa; non si aggregano, alle panchine del quartiere, o in qualche angolo delle palazzine.
Non ci sono nemmeno i campi di grano, né le cantine buie dove respirare piano, né le stanze senza più pareti.
Distratti da altre attività, per lo più virtuali, non socializzano, al di là dei così detti “social network”, che per quanto emotivamente coinvolgenti, escludono però la dimensione concreta, come invece avveniva in quegli anni Settanta, in cui si viveva praticamente insieme e si condividevano non i link su Facebook, ma un destino in comune di un’intera generazione, una vera e propria educazione sentimentale.
I bambini non sono mai stati così soli come oggi, quando le diverse abitudini, nell’articolazione dell’infanzia prima, e della gioventù poi, l’eclissarsi dei punti di riferimento ideali e materiali costituiti dai genitori, le trasformazioni epocali della famiglia, li spingono a cercare altri modelli, finendo per approdare nell’uso prima e nell’abuso poi dei nuovi mass-media, con i loro discutibili eroi, problematiche gestioni e spesso del tutto negativi orientamenti.
Dopo alcuni decenni, si è inoltre compiuta la lucida profezia pasoliniana dell’omologazione, che coinvolge l’aspetto fisico e anzi addirittura parte dall’elemento corporeo, per poi strutturarsi in quello ideale, culturalmente dominato dalla globalizzazione consumistica, in termini di persuasione occulta, creazione di falsi bisogni indotti, proposta di marchi da venerare.
Davanti le scuole elementari e medie, s’avanzano strane ragazze, vestite e truccate da adulte, già uniformate ai modelli dominanti della “velina”, dello spettacolo, del facile successo e del denaro, e magari non hanno ancora nemmeno dieci anni d’età; corpulenti, per lo più in sovrappeso, strani ragazzi, spaesati e smarriti, che trovano un precario adattamento nella logica dell’uniformità e nella “sicurezza” del gruppo, che alimenta prepotenza, egoismo e spesso il ricorso alle dimensioni artificiali, quanto letali delle droghe vecchie e nuove.
Sono bambini già grandi, che non vedono l’ora di entrare nel circuito dominante e cominciano subito a uniformarsi al modello unico di comportamento vigente.
Non c’è nessuno – genitori, parenti, rappresentanti delle istituzioni – che proponga loro le vere alternative che passano dalla riaffermazione della cultura, del merito, del talento, delle attitudini: così, essi non hanno entusiasmo alcuno, non credono più in nulla, sono spaventati dal futuro e sfiduciati per la propria realizzazione.
Le famiglie, o, meglio, quel che ne rimane di esse, del modello tradizionale, sono ugualmente sole.
Non esiste più quel comune sentire, quel mutuo soccorso, quella semplice, ma fondamentale condivisione delle opere e dei giorni, che esisteva fino a trenta, quaranta anni fa.
Allora fra le famiglie dei vicini ci si aiutava l’una con l’altra, nel tenere, o sorvegliare i ragazzi, in caso di assenza per impegni, oppure per una pietanza per il pranzo, o per la cena, come un piatto di verdura, o di legumi, comunque nell’assicurare partecipazione, condivisione, disponibilità, nell’articolazione della quotidianità, e soprattutto nel momento del bisogno.
Nella Santa Rosa dell’epoca un’istituzione erano le “putee”, i negozi di generi alimentari, dove si vendeva “la salame” (chissà perché nel dialetto di Lecce-città è un sostantivo femminile, che va sempre accompagnato dall’articolo), il pane, la pasta, anche sfusa, e quant’altro atteneva all’alimentazione quotidiana delle famiglie.
Abitudine diffusa, che agevolava, anziché contrastare, come sembrerebbe a prima vista, la circolazione di quel poco denaro di cui si aveva disponibilità, era “la libretta” (anche qui al femminile nella vulgata locale), cioè il quaderno, il taccuino, il libriccino o quant’altro su cui l’esercente annotava l’importo della spesa quotidiana, perché poi le famiglie pagavano quando potevano, magari all’arrivo dello stipendio, potendo così disporre di un minimo di liquidità per le altre incombenze, come le bollette da saldare, o scadenze, come le rate degli elettrodomestici.
La carne del macellaio si mangiava solamente la domenica, quando il piatto forte era la pasta “con il sugo di carne” e gli involtini.
Le mie ‘madeleine’ sono gli involtini.
Quando, come mi capita di tanto in tanto, camminando per le strade del quartiere, ne sento ancora adesso quel profumo forte e intenso, che pervade i condomini e arriva fino ai giardinetti, vado ogni volta più di Marcel Proust alla ricerca del mio tempo perduto.
Category: Cronaca