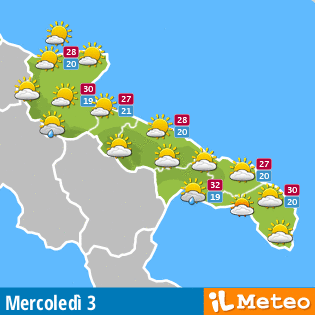PIETRE MILIARI DEL ROCK / RIASCOLTANDO “2” DEL 1999, DEL GRUPPO CALIFORNIANO The Black Heart Procession
 di Roberto Molle______
di Roberto Molle______
Guardarsi dentro, nel profondo, può essere un’esperienza affascinante e dolorosa allo stesso tempo. Mettersi a nudo comporta un sacrificio enorme, vuol dire liberarsi dagli inganni del quotidiano e dalle menzogne che soffocano la verità.
La musica può essere d’aiuto in questo viaggio introspettivo. Il suo essere eterea e non palpabile le permette di modellarsi attorno agli stati d’animo. La musica s’insinua nel pensiero, tra i sentimenti, fornendo uno sfondo dove poter distendere le malinconie.
Ci sono dischi (e non sono tanti nella storia del rock) capaci di assorbire ogni spettro dell’energia emanata dal proprio autore e rilasciarla all’ascoltatore catapultato dentro una sorta di camera anecoica emozionale.

Uno di questi si chiama semplicemente “2”, pubblicato nel 1999 da una delle band più interessanti della scena alt-rock di San Diego (California): The Black Heart Procession.

Il suo mood è commovente, elegiaco e allo stesso tempo di una bellezza disarmante.
Undici brani di straordinario intimismo, capaci di proiettare l’ascoltatore in una dimensione quasi autistica, dove il mondo circostante si eclissa al cospetto di un sole nero.
Sonorità che affondano le radici dentro anni di country, folk, blues, elettronica, legati da un gusto per gli arrangiamenti di grande eleganza. Quello che avviene per i Black Heart Procession è una sorta di sperimentazione ludica, cercando di tirar fuori suoni nuovi da strumenti ‘vecchi’.
Cronologicamente (The Black Heart Procession), sono collocabili nella grande esperienza del rock “intellettuale” degli anni novanta, ma la loro musica sfugge a una definizione netta, precisa. E questo la dice lunga sulla qualità del gruppo, capace di coniare un linguaggio originale, perfettamente distinguibile.
The Black Heart Procession si costituiscono nel 1997 come progetto parallelo di due membri dei “Three Mile Pilot” (altra storica band di San Diego): il cantante Pall Jenkins e il tastierista Tobias Nathaniel. Di lì a poco entrerà in formazione Mario Rubalcaba alla batteria e il gruppo nel 1998, darà alle stampe il primo album (ispirato al songwriting noir) dal titolo “1”.
Chii scrive si è invaghito prima del terzo album dei Black Heart Procession (quel “3” pubblicato nel 2000 che segnerà la fine degli album col titolo cronologico, arriveranno poi “Amore del tropico”, “The Spell”, “Six”, più altri EP), per poi innamorarsi di “2” perdutamente.
Inserire il cd nel lettore e inforcare le cuffie aiuta a rievocare sensazioni cristallizzate per più di vent’anni. Parte il primo brano, “The Waiter #2”, e la magia si materializza: un vento cosmico spira tra ululati lontanissimi e frammenti elettronici disintegrati, poi rintocchi leggeri di piano prendono la scena, scanditi da battiti che riecheggiano nella notte. Il groove è dolente, la musica scheletrica, essenziale, oscura; un’atmosfera gelida avvolge tutto. Dentro un paesaggio in bianco e nero del negativo di uno scatto fotografico risuona la voce abulica di Pall Jenkins che declama lentamente parole pregne di un pathos che regala fitte al cuore. Tutto si consuma in quattro minuti, il brano si spegne con la stessa rarefatta eleganza con cui era iniziato.
Il silenzio tra i solchi conduce a “Blue Tears”, una processione che avanza tra suoni di strumenti così lontani dalle atmosfere umbratili del disco: un accordion, un organetto e una tromba, allineati in un valzer onirico che si fa epico e struggente, capace di far ridere e piangere. Impossibile restare indifferenti a quella che si presenta come una ballata spettrale, si resta sospesi nel dubbio di essere al cospetto di un elogio funebre o a una dichiarazione d’amore. “A light So Dim” entra in sordina, annunciata da rintocchi destrutturati. Un trip-hop acustico accompagnato da possenti note di pianoforte diluito lungo sette minuti che scorrono senza pesare, tanta è la dolcezza che ne scaturisce. Un flusso che culla come una risacca marina e si dissolve inquietante tra nebulose elettroniche.
Quindi è la volta di “Your Church Is Red”, un organo crepuscolare accompagna il sussurro di Jenkins ricamato da scintille di chitarra. Poi, una pallida luna eclissa un sole al tramonto in “When We Reach The Hill”. Solo il freddo suono di un moog e un giro scarno di chitarra acustica ad accompagnare la desolata voce di Pal Jenkins che si muove nell’oscurità come un bardo esiliato.
Un vento di gelida elettronica spira tra le scarne trame di un brano che fa dell’essenzialità il suo punto di forza. Se la solitudine potesse suonare, suonerebbe così.
Dopo tanta oscurità arriva “Outside The Glass”, tastiere calde e riverberi ancestrali che trasmutano in una insolita ninna nanna. Ma dura poco, è ancora inquietudine. In “Gently Of The Edge”, una tromba ubriaca soffia su accordi subliminali creati da tasti elettronici. Ma tutto si gioca su un’armonica distribuzione di ogni cosa, non c’è niente di più e niente di meno.
Tutto è dosato, essenziale, evocativo.
Il ritmo, ricompare nuovamente in “It’s A Crime I Never Told You About The Diamonds In Your Eyes”, titolo dolcissimo e chilometrico, per il pezzo forse più energico di tutto il disco. È sempre il piano ad aprire le danze, questa volta però con più convinzione, stesso proposito seguito dalla batteria, quasi sferzante nel suo incedere. Jenkins si esprime sempre nel solito lamento, ma stavolta dalle sue invocazioni pare trasparire quasi un sentimento di rabbia, una più ferma convinzione.
Come in un gioco di chiaro-scuri i Black Heart Procession sembrano quasi divertirsi nell’accostare in successione brani dal diverso umore.
Intendiamoci, le atmosfere si dipanano sempre fra tramonto e notte, il sole nella loro San Diego non albeggia mai, ma questo leggero contrasto contribuisce a rendere meno monotono il lavoro. Esempio di ciò è il ritorno al blu profondo di “My Heart Might Be Stop”, contraltare perfetto del brano precedente. Sono ancora i tasti del pianoforte a scuotere il cuore, questa volta picchiati con una forza che incute quasi timore.
Segue il pezzo più sperimentale del disco, la sporca indefinibilità di “Beneath The Ground”, tra percussioni sintetiche e note ipnotiche di tastiere. La stessa voce di Jenkins è trattata come mai lo era stata in precedenza, ridotta a elemento di disturbo, impersonale, avvolta da una spirale onirica.
Il viaggio termina da dove era iniziato, e cioè con “The Waiter #3”, una reprise del primo brano con un groove leggermente più accentuato e con Jenkins che pare più stanco, come provato dall’esperienza del dolore. Questa scelta evidenzia la caratteristica ‘circolare’ del disco, e ne fa quasi un concept sulla delusione e la speranza.
La “processione dei cuori neri” è terminata, ma il suo lascito rimarrà per sempre come uno dei momenti più alti di tutti gli anni Novanta, un angolo buio di tutto il post-rock.
Brani da “2” (The Black Heart Procession)
Category: Cultura