“Ti voglio un falò di bene. Chiamiamolo l’ultimo guizzo della candela. Non so se ci vedremo ancora”. LETTURE E RILETTURE: A SETTANTA ANNI DALLA MORTE, E’ L’ESTATE DI CESARE PAVESE, DEI SUOI AMORI FALLIMENTARI. E PURE DEL SUO TORMENTATO RAPPORTO CON LA POLITICA
 di Giuseppe Puppo______
di Giuseppe Puppo______
La sera del 26 agosto dell’anno di grazia 1950, Cesare Pavese, già affermato e brillante intellettuale, al culmine di una disperata crisi esistenziale, prese i primi portici di via Roma a Torino, fece pochi passi, si fermò davanti all’hotel omonimo di piazza Carlo Felice e salì le ultime scale della sua vita.
In camera, quella notte, portò a compimento tutto quello che di disperato e disperante aveva maturato negli ultimi giorni, e diede le sue dimissioni irrevocabili dal mestiere di vivere.
Prese un’overdose di farmaci ed aspettò di guardare quegli occhi che aveva lucidamente prefigurato, il tempo appena di lasciare un biglietto sul suo letto: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”.
Poi rilesse aspettando la morte che veniva, rilesse l’ultima lettera che aveva scritto pochi giorni prima: “Posso dirti, amore, che non mi sono mai svegliato con una donna mia al fianco, che chi ho amato non mi ha mai preso sul serio, e che ignoro lo sguardo di riconoscenza che una donna rivolge a un uomo? E ricordarti che, per via del lavoro che ho fatto, ho avuto i nervi sempre tesi, e la fantasia pronta e precisa, e il gusto delle confidenze altrui? E che sono al mondo da quarantadue anni? Non si può bruciare la candela dalle due parti – nel mio caso l’ho bruciata da una parte sola e la cenere sono i libri che ho scritto.
Tutto questo te lo dico non per impietosirti – so che cosa vale la pietà, in questi casi – ma per chiarezza, perché tu non creda che quando avevo il broncio lo facessi per sport o per rendermi interessante.
Sono ormai di là dalla politica.
L’amore è come la grazia di Dio – l’astuzia non serve.
Quanto a me, ti voglio bene, Pierina, ti voglio un falò di bene. Chiamiamolo l’ultimo guizzo della candela. Non so se ci vedremo ancora. Io lo vorrei – in fondo non voglio che questo – ma mi chiedo sovente che cosa ti consiglierei se fossi tuo fratello. Purtroppo non lo sono. Amore”.
Pierina era l’ultima della serie. Naturalmente, non si chiamava così. Pavese – e io gongolo, oh quanto gongolo e al tempo stesso me ne struggo – non le chiamava mai con il loro vero nome, ma con uno pseudonimo che si inventava di volta in volta per l’occasione, per scriverne su una specie di diario, di blocco di appunti, che portava sempre con sé.
Pierina per la cronaca era una ragazza di 18 anni, una liceale appena maggiorenne, Romilda Bollati, sorella dell’editore Giulio Bollati, appartenente alla nobile famiglia torinese dei Bollati di Saint-Pierre, appena conosciuta durante una vacanza organizzata dalla casa editrice Einaudi in Liguria.
Un flirt di pochi giorni, un’avventura di breve durata, innocenti evasioni. Ma vaglielo a spiegare…Cesare Pavese, incapace di discernere e impaziente di dare un volto ai fantasmi delle proprie insoddisfazioni sessuali e sentimentali, ogni volta partiva subito lancia in resta all’assalto animato dai più eroici furori, senza lasciar decantare, senza poter, com’è necessario, valutare alla luce del tempo.
Poi, se le sceglieva tutte sbagliate, le sue pseudo Beatrice del Dolce Stil Novo. Fra tante che avrebbe potuto avere, scartava possibilità d’occasione che non lo interessavano, il tanto per basta che respira non lo aveva mai interessato, ma ogni volta si andava a scegliere, puntualmente, inesorabilmente, quella sbagliata, ma sbagliata a tal punto che sarebbe stato facile capirlo subito. E niente, invece no, lui ci credeva, partiva, subito e subito finiva regolarmente disarcionato, a mangiare la polvere. Se le trovava tutte così, con il lanternino, incredibile.
E una cosa tranquilla, una storia semplice, no eh? Ma per lui l’amore non era mai un comodo aggiustamento, per lui l’amore era sempre uno scomodo sconvolgimento.
Fu così fin dal suo primo amore, quando era ancora giovane diciassettenne liceale al “D’Azeglio” e si prese una cotta terribile per una cantante ballerina di un locale frequentato dagli studenti. In un modo o nell’altro riuscì a darle un appuntamento e stette ad aspettarla all’uscita per sei ore, dalle 18.00 alle 24.00, quando passò l’ultimo tram, sotto la pioggia battente, perché intanto era venuto giù un temporale che la metà bastava, e quella non si fece vedere, perché evidentemente aveva avuto di meglio con cui intrattenersi. Così non gli restò altro da fare che tornarsene a casa, talmente bagnato fradicio, che gli venne subito una bronchite degenerata in pleurite, che lo tenne a lungo fra la vita e la morte.
Cesare di cui canta Francesco De Gregori nella sua famosa canzone del 1973 “Alice non lo sa”, è proprio lui.
Per un’altra donna sbagliata, la “donna dalla voce rauca”, al secolo Tina Pizzardo, ma lui la chiamava così, attiva nella fronda antifascista torinese, si mise nei guai con la politica, lui che della politica sostanzialmente se ne fregava, perché si interessava solamente di letteratura e anzi si era già appassionato di letteratura nord americana, e finì al confino.
Riuscì a venirne fuori poco dopo, scrivendo lettere di elogio a Benito Mussolini. Tutte regolarmente omesse dalla cultura ufficiale. Non si trattava di un espediente opportunistico. Dall’altro versante, invece si trattò di vera e propria omissione. La cultura antifascista del Dopoguerra che aveva fatto di Cesare Pavese un’icona, non poteva tollerare certi trascorsi, che ometteva e basta, come fece per tanto tempo anche con il padre dell’antifascismo torinese, il mostro sacro Norberto Bobbio.
Ogni tanto spuntano fuori, però. In questi giorni dell’estate 2020, settantesimo anniversario della morte, sono stati appena ripubblicati certi appunti imbarazzanti, risalenti al periodo finale della Seconda Guerra Mondiale, in cui lo scrittore criticava gli antifascisti e simpatizzava per la repubblica Sociale Italiana.
Amen.
Ma dove eravamo rimasti? Ah, sì, la passione per la letteratura nord americana contemporanea , fondamentale per l’intera letteratura italiana. Ne fu contagiato da Fernanda Pivano, che divenne poi importantissima, F. da lui così appellata, all’epoca però universitaria di belle speranze, che dell’amore di quel trentaduenne tanto complicato non ne volle sapere, malgrado, nell’ordine, decine di bigliettini, tre poesie, e due proposte di matrimonio, una subito, una cinque anni dopo: le date in cui le rivolse, precise sono riportate nel suo diario, con, disegnata accanto, una croce.
Cinque anni di tira e molla, strazianti per lui, che non poteva accettare la riductio ad amico cui era stato da lei declassato.
Ma quali buoni amici, maledetti?!? Canterà a tal proposito Gianluca Grignani, in “La mia storia tra le dita”.
L’altra storia che scivolò fra le dita martoriate di Cesare Pavese, fu poi a Roma, all’ufficio dell’Einaudi, dove era costretto a fingere di interessarsi di politica per conto del Pci, il che gli procurò una depressione maggiore, acuita a breve dall’amore, che te lo dico a fare? non ricambiato, per la segretaria di redazione, tal Bianca Garufi, semplicemente B. nei suoi diari.
Ma il peggio doveva ancora venire, e verrà con gli occhi della morte dell’ attrice, di Constance Dowling (nella foto di copertina, in una scena del film ‘Black angel’ del 1946; nella foto qui sotto, durante un incontro mondano a Roma insieme allo scrittore), che gliene combinò di tutti i colori: lo illuse, perché era una comparsa di belle speranze, venuta a Roma in cerca di fortuna a Cinecittà e le faceva comodo avere aderenze negli ambienti culturali della capitale; gli mise accanto a palliativo la sorella Doris; lo portò in vacanza a Cervinia e qui lo tradì, insomma, tradire non è il verbo adatto, ma mentre gli faceva credere di essere andata in montagna per lui e con lui, coltivava la tresca con un collega attore italiano associato alla bella vacanza, per poi ritornarsene in America subito dopo.
Infine, la Pierina diciottenne della quale abbiamo raccontato all’inizio.
Gli restavano gli occhi di Constance, e ancora poche frasi da vergare sul frontespizio di un libro, in cui aveva sistemato il bigliettino delle scuse, mentre arrivava l’alba del 27 agosto 1950 che egli non vide mai: “L’uomo mortale, Leucò, non ha che questo d’immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia. Ho lavorato, ho dato poesia agli uomini, ho condiviso le pene di molti. Ho cercato me stesso”.______

BIBLIOGRAFIA
Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950, Torino, Einaudi, 1952
Vita attraverso le lettere, a cura di Lorenzo Mondo, Torino, Einaudi, 1973,
Il taccuino inedito, a cura e con un saggio di Francesca Belviso, introduzione di Angelo d’Orsi, con un testo di Lorenzo Mondo, Appendici documentali, Torino, Aragno, 2020
Tutte Le poesie, Torino, Einaudi, 2020.










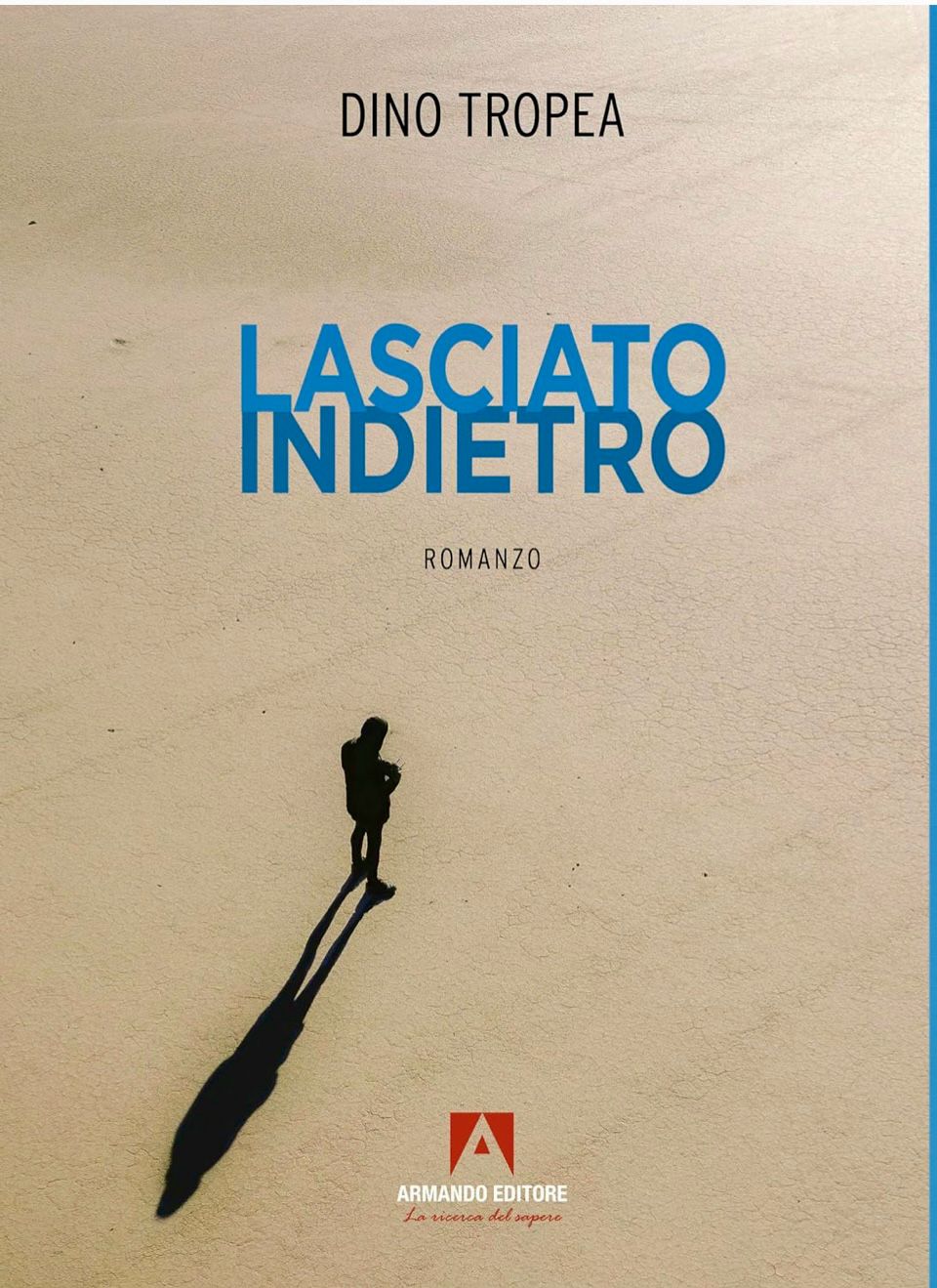
















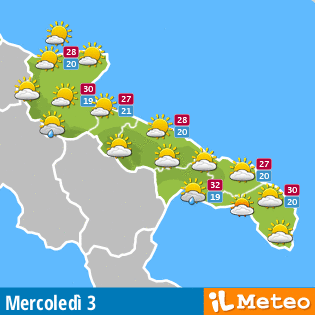









Fantastico! Grazie direttore