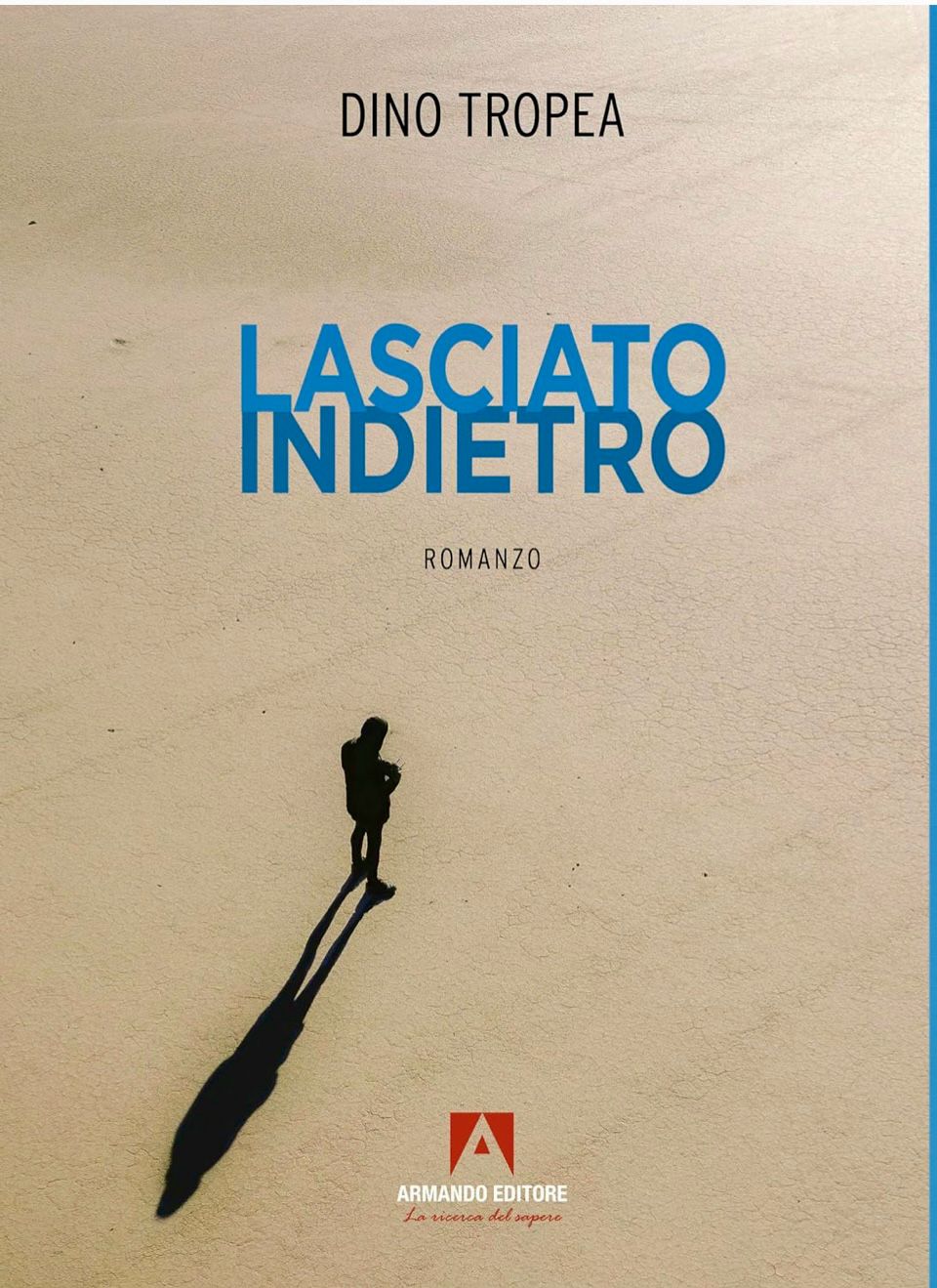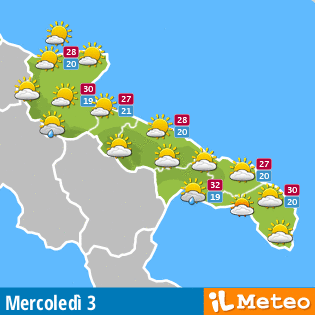“Ti scrivo da una parete verticale“
 di Teresa Ciulli ______
di Teresa Ciulli ______
Ho una mamma della pancia, alcune mamme del cuore; donne che mi spronarono a tirare fuori il meglio di me stessa non per professione ma per amicizia, aspetto che cambia completamente la natura del dono ricevuto perché lo rende inviolabile, incorruttibile.
Ho anche, è il caso di saperlo, una mamma mitocondriale. E quella mamma, Attenzione! E’ la stessa per ciascuno di noi.
Quando l’ho scoperto sono stata folgorata.
Ho fatto fatica a crederci. Il patrimonio genetico che riposa nei nostri mitocondri, le minuscole fabbriche di energia che punteggiano il citoplasma, la gelatina che avvolge il nucleo all’interno della cellula, bene, quei filamenti di DNA dentro ogni singolo mitocondrio, numeri metafisici se pensiamo che siamo costituiti da una media di 37.000 miliardi di cellule è lo stesso, è uguale, per tutti. A prescindere dalla razza.
Ce lo tramandiamo da duecentomila anni. La chiamano, i biologici, questa mamma universale che ce lo ha tramandato, Eva Mitocondriale.
A me batte il cuore all’impazzata a pensarci. Lei è davvero la prima donna della nostra vita.
E’ proprio esistita, ci sono almeno otto miliardi e duecento milioni di prove certe.
Eva è vissuta in foreste di cui non sapremo mai. Galleggiava il suo cuore fra una trapunta di stelle, la notte. Di quelle sapremo mai. Immerso il suo orecchio fra centinaia migliaia di suoni enigmatici: terrificanti incantevoli acuti bassi struggenti. Milioni le specie scomparse.
La mia mamma, e la tua, somigliava un tantino a una scimmia. Sapeva salire sugli alberi e da lì sopra, il suo scrutare si perdeva fra milioni di chiome. Sapeva correre benissimo, svelta coraggiosa, forti le sue gambe, robuste. Aveva qualcosa lei in più delle altre del suo gruppo, ma non lo sapeva. Nessuno fino a qualche anno fa, lo sapeva. Moltissimi studi hanno dimostrato questa inequivocabile parentela. Siamo tutti, tutti figli della stessa madre.
Riceviamo il patrimonio mitocondriale per discendenza materna. Lo spermatozoo non possiede che il suo corredo genetico e quella lunga coda che gli consente di scivolare velocissimo verso l’ignoto. E’ la sua determinazione: correre fra le pieghe umide della vagina. Correre quando risale il canale cervicale quando si disorienta all’interno dell’utero e quando ha ancora fiato per infilarsi dentro un canale, la tuba, scrollandosi di dosso quegli altri che lo spingono strattonano, addirittura scavalcano. Quando con quella grande testa tocca la membrana, sprofonda. Sembra sciogliersi. Si agita ancora, a rallentatore, fra i mitocondri di Eva e poi ancora urta. Per l’ultima volta.
Bussa. Aprimi, sono io.
Io, chi?
Io, tua figlia. Tuo figlio.
E’ un dialogo antichissimo che ha riguardato e che ancora riguarda ogni essere vivente sulla terra. In forma rudimentale, mediata dal vento dalle api dalle volpi, dalla cacca, concerne anche il mondo vegetale.
E’ un dato di fatto, la vita ha selezionato solo forme capaci di riprodursi. Le altre sono scomparse per sempre.
Tuttavia accade abortire. Qualche volta si inceppa l’incantevole sviluppo embrionale, e qualche volta tocca che lo decido io. A me è successo. Ero ragazza. E’ un trauma insuperabile: fare violenza a sé stessi è il danno più osceno dell’Universo. Se tocca farlo è perché una vergogna più grande incombe sulla mia esistenza. O che si vive che si interpreta e, o che gli altri ti restituiscono, come tale. La realtà è una roba complessa non è quella in cui è vissuta la mia mamma mitocondriale. Duecentomila anni fa, dondolandosi fra i rami.
Che in Francia, abbiano inserito il diritto all’aborto nella Costituzione a me sembra un grande passo avanti nella parità di genere. La vita è un dono gratuito. Di Dio, qualunque nome abbia, dei miei genitori. Ma esiste la possibilità, esiste, che io non possa farti quel dono. Non posso donarti la vita perché la tua confligge con la mia e con quella delle persone da cui dipendo. Sono senza futuro; sono materia oscura a me stessa, sono un corpo dove confluiscono interessi, appetiti, ambizioni finemente tritati, miei e altrui. La cultura la società i miei genitori, io stessa, ci siamo fatti derubare di dignità. Non sono io a indirizzare la vita è la mia debolezza a scrivere la storia. Non possiedo dignità, non ho potere. E’ straziante. E’ un suicidio. Un’amputazione della Speranza.
Nascere è nascere al rispetto. Quello dei tuoi genitori quello del gruppo quello della società a cui appartieni.
Io credo di essere nata poco tempo fa al rispetto. All’amore per me stessa. Ho sessantatré anni. Ho scalato un Everest di insicurezze, di paura, di malattie. Ti scrivo da una parete verticale.
Appartengo a una cultura che quelle paure si diverte a moltiplicarle, che manipola demagogicamente ogni discorso sulla maternità invece di demolire le barriere di genere, la discriminazione salariale e culturale, l’embargo razziale. Cose che cristallizzano le differenze sociali senza risolvere le vulnerabilità scardinare le diseguaglianze e soprattutto risolvere il problema della dipendenza.
Non è sufficiente avere un portafoglio in mano per essere autonome.
Serve accendere luci da stadio su ogni discorso in casa a scuola in tram in televisione, in cui viene fatto a pezzi il rispetto e l’educazione, il guscio sacro che circonda ogni essere vivente. Ogni. Tutti. Senza distinzione di genere. Incluso l’albero il vento la mosca.
Se questo rispetto non siamo in grado di esercitarlo nei confronti dei già vivi, e della terra e del cosmo, come possiamo pensare, immaginare, desiderare di agire nei confronti dei non ancora nati?
Lo sforzo è indignarmi, alzarmi, denunciare la cultura che si fa manipolativa: subdolamente violenta. Quando si identifica in un pensiero che divide, umilia, giudica. Pensiero che semplifica ammucchia, rapina i deboli. I poveri, gli analfabeti, gli anziani. Le donne. La cultura quando assolda la Religione per asservire le coscienze; impaurirle. Consegnarle all’Inferno; sulla Terra però.
La cultura che fonda le sue certezze sulla verità non è evolutiva. E tuttavia se al suo interno esistono gli anticorpi che consentono di guardarmi dall’esterno, di sapere e vedere la gabbia in cui sono chiusa, non è tutta da buttare.
La chiave giace sul pavimento, nella cella. A meno di un metro dalla mia mano. Fa paura uscire.
Alla paura sono stata educata ad ubbidire tutta la mia vita.
Ma qualcosa non ha funzionato, vedi, ho partorito la mia voce.
______
(Teresa Ciulli, Lecce, 15 marzo 2024, testo e illustrazione per leccecronaca.it)
Category: Cultura