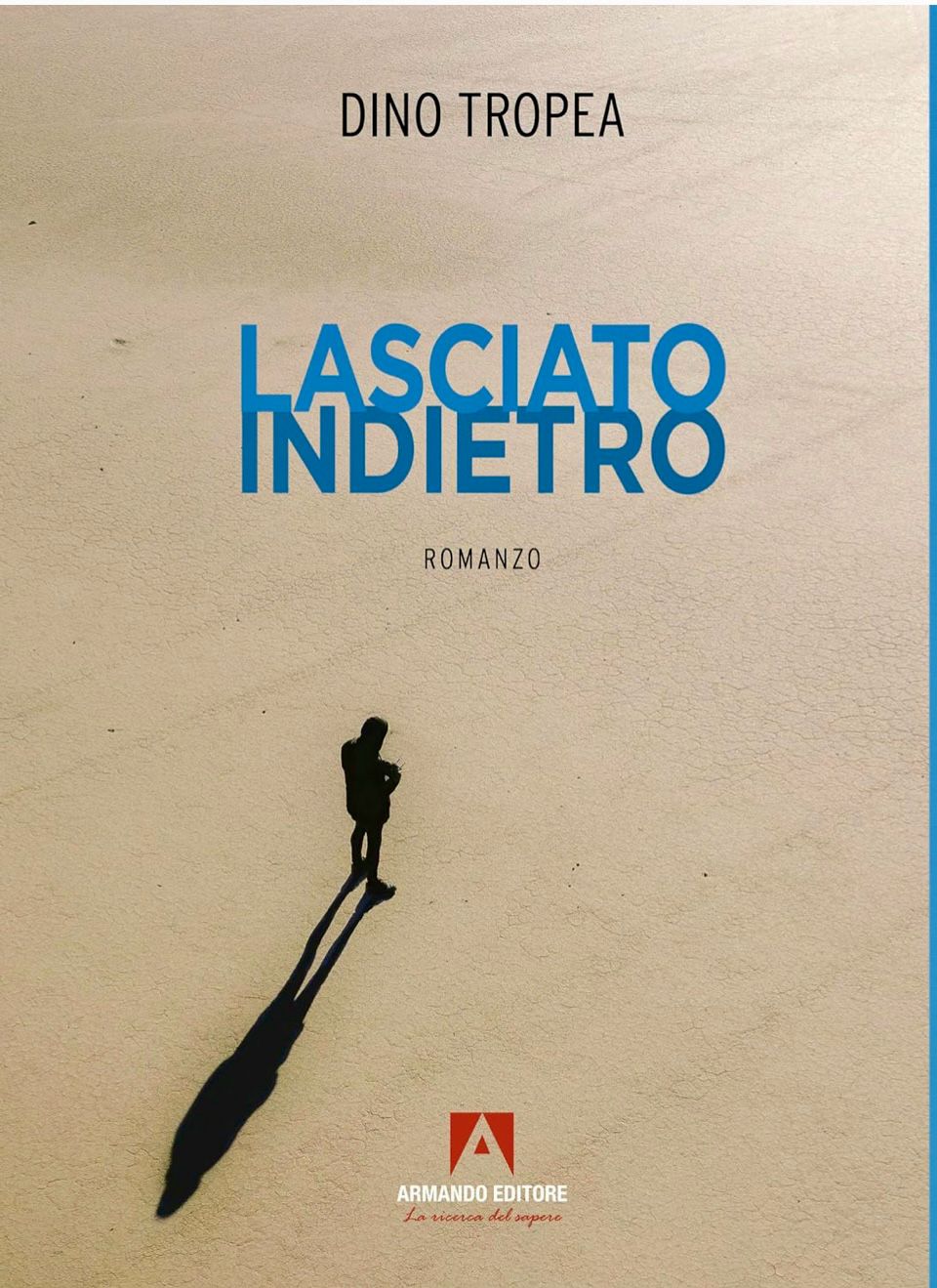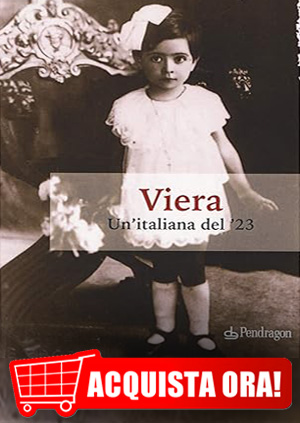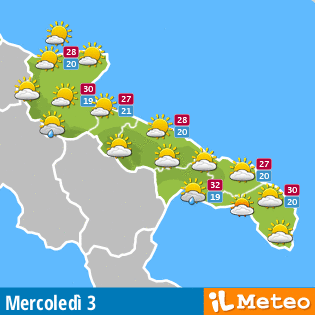LA SCRITTRICE PAOLA MATTIOLI IN “Viera” HA RIPERCORSO LA VITA DELLA MADRE, LA STORIA DI TUTTA UNA GENERAZIONE

di Cristina Pipoli _____________
Cos’è la memoria se non un fiume dal letto stretto e con poca acqua che, al tempo del disgelo, si scopre improvvisamente gonfio, capace di travolgere il presente con la forza dei ricordi?
Tutto comincia da quel fluire. La nonna paterna di Viera si chiamava Paola, lo stesso nome che Viera darà a sua figlia, la curatrice del volume Paola Mattioli per le Edizioni Pendragon.
In quel riverbero di nomi si nasconde un destino fatto di acqua e di fatica. Si vedono ancora, nitide tra le pagine del quaderno verde, le donne della famiglia — la nonna e le zie — incamminarsi verso il fiume per lavare i panni.
Non era un gioco, era un rituale di sopravvivenza. In quelle antiche tradizioni rurali, il fiume diventava l’altare della resistenza femminile. Bisogna imaginarle, queste donne, chinate sulle pietre con la schiena curva e lo sguardo fiero, mentre combattono contro lo sporco e la corrente. Qui emerge la forza delle braccia, muscoli tesi dal lavoro che non concedeva sconti, capaci di strizzare lenzuola pesanti come macigni e, allo stesso tempo, di sorreggere il peso di intere generazioni. Era un mondo dove la dignità passava per la fatica fisica, un’eredità di muscoli e volontà che Viera ha assorbito fin dal suo primo vagito nel 1923.
Viera cresce tra due ritmi opposti, due suoni che diventano le coordinate del suo mondo. In casa, regna la cadenza metallica e ipnotica dei ferretti da maglia. Sua madre è una magliaia: una di quelle figure centrali dell’economia domestica del tempo, capaci di trasformare un filo di lana in un’armatura contro il freddo. In quel ticchettio costante, Viera impara la pazienza della precisione, l’arte di costruire qualcosa punto dopo punto, senza mai saltarne uno. È il tempo dell’attesa e della cura, dove ogni maglia chiusa è un piccolo traguardo di stabilità.
Fuori da quelle mura, però, il mondo ha il sapore della velocità e il profumo pungente degli oli lubrificanti. Suo padre è un rappresentante, un uomo del movimento: viaggia portando con sé campionari di cereali e fusti di olio per motori, simboli di un’Italia che sta faticosamente cercando di meccanizzarsi. Torna tardi ogni sera, con la stanchezza di chi ha macinato chilometri, ma la domenica tutto cambia.
La domenica è il giorno della motocicletta. Viera, la bimba nata nel ’23, viene issata su quel sedile metallico, aggrappata alla schiena del padre. In quel vento che le scompiglia i capelli, si forgia il suo carattere: da una parte la disciplina rigorosa della madre magliaia, dall’altra l’audacia e il desiderio di orizzonti del padre.
Queste professioni non sono solo lavori, sono lezioni di vita.
La madre (magliaia): le insegna che la dignità si costruisce con le mani, con la resistenza silenziosa e la capacità di riparare i fili che si spezzano.
Il padre (rappresentante): le trasmette il coraggio del viaggio, l’importanza di saper “vendere” la propria determinazione e la gioia della libertà su due ruote.
In questo intreccio di lana e acciaio, tra il silenzio del lavoro domestico e il rombo della domenica, Viera assorbe la tempra di un’Italia che non si ferma, preparando lo spirito a quegli anni difficili che di lì a poco avrebbero chiesto a lei, e a tutta la sua generazione, di restare in sella nonostante le intemperie della storia.
In questo scenario di tempra e fatica, tra il rumore dei motori e il ritmo dei ferretti, fiorisce però una grazia inaspettata, la tenerezza che precede il rigore della Storia. È il volto di Lino, il primo amore tra i banchi delle elementari.
In prima elementare, il corteggiamento di Lino è fatto di carta e colori: sono lettere scritte con la grafia incerta dei bambini e disegni dedicati, piccoli messaggi lanciati oltre il confine dei banchi per attirare l’attenzione di Viera. È una forma d’amore ingenua e purissima, che trova il suo culmine l’anno successivo. In seconda elementare, infatti, arriva il gesto che resta impresso nel quaderno della memoria come un sigillo indelebile: un bacio sulla guancia.
Un bacio rubato, forse ricevuto con un rossore improvviso, che rappresenta l’ultimo scampolo di un’infanzia ancora libera dai pesi dell’età adulta. Quel bacio e quei disegni sono le tinte tenui di una Viera bambina, prima che il carattere si faccia roccia, ricordandoci che dietro la donna forte e resiliente di domani c’è stata una piccola alunna che ha imparato l’amore tra un’asta e una lettera, sotto lo sguardo attento di chi sapeva già che il mondo sarebbe presto cambiato.
Ma la vita, che fino a quel momento aveva avuto il sapore della lana pulita e della corsa domenicale, presenta a Viera il primo conto, il più salato. Lino smette di venire a scuola. Il suo banco vuoto diventa improvvisamente un abisso silenzioso tra le file della classe.
Quella che sembrava una banale influenza, un male di stagione in un’epoca in cui la medicina non aveva ancora le armi per proteggere l’infanzia, si trasforma rapidamente in un’ombra senza ritorno. La polmonite si porta via Lino, trasformando quelle lettere e quel bacio sulla guancia in reliquie di un tempo perduto.
È il primo, vero strappo nel tessuto della sua esistenza. Per Viera, quel dolore non è solo la perdita di un compagno di giochi, ma la fine brusca dell’innocenza: scopre che il fiume della vita può essere crudele e che la morte può colpire anche chi ha appena imparato a scrivere il proprio nome. Questo primo lutto forgia in lei una consapevolezza precoce; la bambina che guardava il mondo con gli occhi sognanti di chi riceve disegni, comincia a indossare la corazza di chi deve resistere. Quel dolore indelebile, annotato tra le pagine del quaderno verde, diventa la radice di una resilienza che l’accompagnerà per tutto il secolo.
Qui il racconto di Viera si trasforma in dolore. Mentre l’Italia ufficiale del tempo gonfiava il petto nelle piazze, un’intera generazione veniva soffocata nel silenzio. La morte di Lino non è solo una tragedia biologica, ma lo specchio di un’epoca che preferiva investire nei cannoni del 1923 piuttosto che nella cura. Viera scrive del suo fidanzatino che muore senza respiro: è il racconto di una tragedia che la medicina del tempo non sapeva — o non voleva — affrontare. Si preferiva nascondere la fragilità sotto il tappeto del patriottismo.
Viera non dice l’anno scolastico perché nel 1930 la scuola non insegnava alle donne a contare i propri anni di libertà, ma a contare i figli da dare alla patria. Quello che conta non è la cronologia dei banchi, ma la data in cui ha capito che il suo Lino moriva perché lo Stato ometteva la verità. Questa mancanza di date ci dice che la storia delle donne è stata resa “senza tempo” per essere meglio dimenticata. Ma il suo diario restituisce la verità: quella del respiro tolto dalla malattia e del diritto negato alla parola.
Oggi, nel 2026, la domanda resta: cosa è cambiato? Se ieri si moriva perché la cura era negata o nascosta, oggi rischiamo ancora di scontare le inefficienze di un sistema che si volta dall’altra parte. La storia di Viera, salvata dal silenzio grazie a sua figlia Paola, ci ricorda che la memoria ha il dovere di restituire il respiro a chi è stato soffocato dal silenzio.
Il quaderno verde di Viera non è dunque solo una raccolta di ricordi, ma un silenzioso atto di resistenza contro la Riforma Gentile del 1923. In un’epoca in cui il sistema scolastico cercava di confinare le donne in percorsi di serie B — con i “licei femminili” privi di sbocchi universitari e programmi ridotti all’economia domestica — Viera compie un gesto rivoluzionario: si riappropria della scrittura. Mentre lo Stato voleva l’alfabetizzazione femminile limitata alla gestione del focolare, lei trasforma la penna in uno strumento di pensiero critico.
Scrivendo, Viera contesta indirettamente la “Mistica della Madre” imposta dal Ministero dell’Educazione Nazionale. Laddove la propaganda voleva la donna come fredda “fattrice per la patria”, lei registra il suo dolore, la tenerezza per Lino e la propria individualità. Rimettere al centro il sentimento privato contro il dovere pubblico è la sua personale sfida al regime.
Infine, la mancanza di date precise nel diario documenta il vero fallimento educativo di quegli anni: per le donne del tempo il “tempo storico” era stato cancellato, sostituito dal ritmo biologico della cura. Viera, però, trasforma quel tempo vuoto in una cronaca di vita vera, smascherando l’ipocrisia di una scuola che voleva formare sudditi obbedienti e ritrovando, tra le righe di un quaderno, il diritto negato alla propria parola.
Dare voce a chi, per cent’anni, è rimasto chiuso nel silenzio di un quaderno verde non è solo un atto di memoria: è un dovere di cronaca. Riportare alla luce i nomi di Viera e di Lino significa strapparli all’oblio di uno Stato che li voleva solo numeri, restituendo loro, finalmente, quel respiro e quella dignità che la Storia ha tentato di soffocare.